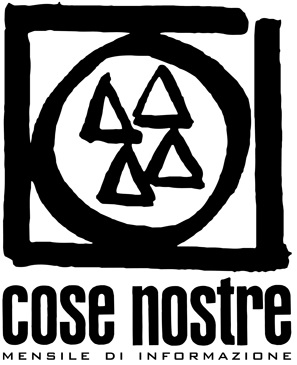Di solito quando si ascolta quella musica generalmente definita come “classica”, molti ascoltatori trovano difficoltà a seguire il filo del discorso e si limitano a godere della piacevolezza dei vari motivi, senza supporre che esiste una forma specifica e una ragione d’essere in ciascun momento di ciò che stanno ascoltando. Ricordo una volta un mio amico, che addirittura commentò: “bello, sì, ma senza capo né coda!” Non ci potrebbe essere un’affermazione più sbagliata.
I brani musicali sono tutti costruiti seguendo formule ben precise, con mattoni disposti in modo logico, e il risultato non è mai mai casuale. Il più facile fra tutti gli schemi è il modello A-B-A, chiamato anche “forma ternaria” o “forma canzone”, dove il tema viene esposto all’inizio e alla fine, con al centro una parte contrastante. Tali sono i “minuetti”, ovvero gli “scherzi”, delle sinfonie, dove la parte centrale “B” viene chiamata “trio” in quanto originariamente era eseguita da tre elementi dell’orchestra, quasi sempre fiati. Una formula più sofisticata di A-B-A è il Rondò, che è un A-B-A-C-A-D-A-E… ecc. a piacere: vale a dire che un motivo sempre diverso e nuovo viene inserito dopo ogni ritorno (“ritornello”) del primo tema. Più tecnico è invece il “tema con variazioni”, che trasforma il tema in tutti i modi possibili (armonici, ritmici, agogici, dinamici); mentre regole ferree governano il principio dell’imitazione e sovrapposizione dei temi in contrappunto (come nella fuga), cosa che non rientra nella presente disamina.
Ma per non perdersi e determinare subito la struttura di una composizione c’è soprattutto un sistema, che, una volta memorizzato, consente di recepire l’architettura del brano dando un senso all’entrata e all’uscita dei vari temi: tale sistema si chiama “forma-sonata”.
Il termine non deve ingannare: non è solo riferibile alle “sonate”, vale a dire ai brani solistici o da camera, ma anche ad apparati di grande importanza, come i concerti o le sinfonie, ed è usato sia nel movimento iniziale che nei finali, e talvolta persino negli Adagi. La “forma-sonata” la si può considerare un’invenzione escogitata per aiutare l’ascoltatore a orientarsi nel mare dei suoni. Fu la sua presenza a determinare la costante crescita del successo della musica strumentale: in tal modo “la singola forma del brano veniva facilmente individuata al momento dell’esecuzione pubblica, mantenendo vivo l’interesse di un pubblico numeroso” (così David Rosen). Il sistema si impose a partire dagli anni ’30 del ‘700 come una vera e propria razionalizzazione illuministica della sostanza fonica. Si basa su uno schema ternario che non potrebbe essere più semplice di così: Esposizione – Sviluppo – Ripresa.
Nella prima sezione Esposizione viene presentato il materiale tematico, di solito in regime di bitematismo, ma i temi possono essere anche più numerosi, cinque o sei, e collegati da ponti modulanti; inoltre, poiché il compositore sa che è indispensabile che tale materiale si imprima bene nella mente dell’ascoltatore, viene prevista la sua ripetizione integrale (col segno di doppia stanghetta). I temi, o i gruppi tematici – ad esempio rimico o mosso il primo, più dolce e delicato il secondo – sono sempre in tonalità contrastanti, anche se a dominare è la tonalità principale del primo gruppo.
Il successivo Sviluppo (che è il “cuore” della composizione) ha lo scopo di intensificare la tensione introdotta dall’Esposizione. Dal materiale precedente viene estratta una parte, un tema, o la testa di un tema, o anche solo tre o quattro note, che vengono lavorate, alterate, sovrapposte, contrapposte a formare nuovi temi, con effetto di una crescita coerente e organica e spesso con un consistente aumento dell’effetto drammatico. Ci sono sviluppi concisi, brevissimi, o sviluppi giganteschi, monumentali, però tutti convergono verso il bisogno di giungere alla “ripresa”, a volte usando, per stupire l’ascoltatore, delle “false riprese”.
Ma quando poi la terza sezione, la Ripresa, giunge realmente, l’effetto di questo ritorno ingenera un meraviglioso ed atteso colpo di scena. Non si tratta mai di una semplice ripetizione del materiale ascoltato all’inizio, ma di un riadattamento, di un’amplificazione, che porta alla “coda” con cui si chiuderà il brano. “Il principio della ripresa” dice sempre il Rosen “è da considerarsi come l’innovazione più fondamentale e radicale”.
Tenendo a mente quanto sopra detto si può seguire agevolmente il percorso di ogni composizione, orientandosi anche nel caso che si ascolti un brano per la prima volta. Da notare che questo meraviglioso schema (che ha molte varianti ed è flessibilissimo nella sua attuazione) è stato la base su cui furono costruiti tutti i più grandi capolavori dall’epoca rococò al classicismo e al romanticismo fino al ‘900, e che non è ancora stato accantonato o tralasciato, nemmeno ai giorni nostri: vi assicuro che se vi abituerete ad ascoltare con questa elasticità mentale, ne sarete ampiamente ripagati!