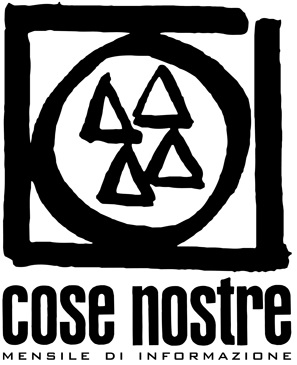L’ondata di moti insurrezionali contro i regimi assolutistici del 1848 che prese nome di “La primavera dei popoli” rappresentò il terzo atto del tentativo ottocentesco di autodeterminazione degli stati dopo i movimenti di protesta dei bienni del 1820-21 e del 1830-31. Non furono coinvolti nei disordini la Gran Bretagna che sotto il regno della regina Vittoria stava godendo di un periodo di stabilità politica ed economica e la Russia, la quale non disponeva di classe borghese e scontava la arretratezza socio-economica del suo sistema semifeudale. I contrasti sociali già emersi nel precedente ventennio riesplosero con tutta la loro virulenza con la crisi economica del 1846 nel settore dell’agricoltura e che era cominciata con dei cattivi raccolti di patate in Irlanda. I moti non ebbero un carattere unitario ma si differenziarono da luogo a luogo. In alcuni casi, come in Germania e in Italia, le richieste di una Costituzione e di riforme sociali si legarono all’aspirazione di raggiungere l’indipendenza e l’unità nazionale. Uno dei tratti tipici di questi movimenti fu che coinvolsero, oltre alla borghesia e agli studenti, anche variegati strati popolari, dai contadini nelle campagne agli operai nelle città.
L’ondata di moti insurrezionali contro i regimi assolutistici del 1848 che prese nome di “La primavera dei popoli” rappresentò il terzo atto del tentativo ottocentesco di autodeterminazione degli stati dopo i movimenti di protesta dei bienni del 1820-21 e del 1830-31. Non furono coinvolti nei disordini la Gran Bretagna che sotto il regno della regina Vittoria stava godendo di un periodo di stabilità politica ed economica e la Russia, la quale non disponeva di classe borghese e scontava la arretratezza socio-economica del suo sistema semifeudale. I contrasti sociali già emersi nel precedente ventennio riesplosero con tutta la loro virulenza con la crisi economica del 1846 nel settore dell’agricoltura e che era cominciata con dei cattivi raccolti di patate in Irlanda. I moti non ebbero un carattere unitario ma si differenziarono da luogo a luogo. In alcuni casi, come in Germania e in Italia, le richieste di una Costituzione e di riforme sociali si legarono all’aspirazione di raggiungere l’indipendenza e l’unità nazionale. Uno dei tratti tipici di questi movimenti fu che coinvolsero, oltre alla borghesia e agli studenti, anche variegati strati popolari, dai contadini nelle campagne agli operai nelle città.
La rivolta negli stati italiani iniziò il 12 gennaio a Palermo, nel Regno delle due Sicilie sotto il dominio di Ferdinando II di Borbone. A differenza delle precedenti proteste che prendevano forma in modo segreto e silenzioso, l’organizzazione in questo caso avvenne attraverso la distribuzione di volantini tra la popolazione e tramite l’affissione di manifesti lungo le strade della città. Già a fine gennaio venne concessa la Costituzione e a giugno la Sicilia diventò Stato di Sicilia con un governo costituzionale. La notizia dei moti nell’isola provocò la diffusione della rivolta anche negli altri stati italiani, in primis nel Regno di Sardegna dove il 4 marzo Re Carlo Alberto concesse ai sudditi lo Statuto Albertino, documento suddiviso in quattordici punti e che è di particolare importanza in quanto diverrà la legge fondamentale del futuro Regno d’Italia. Lo Statuto stabilì una Camera dei deputati ad elezione su base del censo e un Senato di nomina regia e il cattolicesimo come religione di Stato. L’idea che aveva spinto il sovrano piemontese a promulgare lo Statuto, e lo si evince già dal nome assegnatogli, è che era meglio una costituzione concessa per volontà regia rispetto ad una ottenuta tramite una rivoluzione. Anche il granduca di Toscana, Leopoldo II, e il pontefice Pio IX, per quietare gli animi degli insorti dei rispettivi domini, decisero di concedere la Costituzione.
Sull’onda delle rivoluzioni a carattere etnico scoppiate a Praga, a Vienna e a Budapest che provocarono la caduta del cancelliere austriaco Metternich e la concessione da parte dell’Imperatore Ferdinando I di alcune riforme come la libertà di stampa e la promessa di una costituzione, anche Venezia e Milano insorsero contro l’Impero Asburgico per ottenere l’indipendenza. Nel capoluogo veneto il 17 marzo una grande manifestazione popolare chiese la liberazione dei detenuti politici tra cui il capo dei democratici Carlo Cattaneo. Si sollevarono anche gli operai dell’Arsenale militare a cui si unirono i membri della marina asburgica e il 23 marzo il governo provvisorio presieduto da Daniele Manin proclamò la Repubblica di Venezia e sul campanile di San Marco ritornò a sventolare il gonfalone raffigurante il leone alato.
Il 18 marzo la popolazione milanese si riversò per le vie della città in una protesta pacifica contro l’impero austro-ungarico ma in breve tempo si trasformò in un violento scontro tra i manifestanti e l’esercito austriaco. Iniziarono così le cinque giornate di Milano che fecero della città un campo di battaglia con la costruzione di numerosissime barricate da parte dei dimostranti al fine di contrastare il nemico. Il 22 marzo gli insorti riuscirono ad espugnare alcuni palazzi occupati dagli austriaci e così ebbe inizio la ritirata di Radetzsky fino al quadrilatero delimitato dalle fortezze di Verona, Legnano, Mantova e Peschiera. Carlo Alberto vedendo gli austriaci in difficoltà colse l’occasione al balzo e il giorno seguente dichiarò guerra all’Impero Asburgico. Ebbe così inizio la prima guerra di indipendenza italiana. In un primo momento si unirono alla guerra antiaustriaca anche Ferdinando di Borbone, Leopoldo II di Toscana e papa Pio IX. Questo iniziale entusiasmo si spense quasi subito a causa della scarsa determinazione di Carlo Alberto, soprannominato “il re tentenna”, che manifestava il timore che la guerra piemontese di conquista del Lombardo-Veneto si trasformasse in un centro di agitazione di stampo democratico. La campagna militare di Carlo Alberto si rivelò vincente nei primi scontri ma poi si arenò a causa della lentezza nell’organizzazione delle truppe sabaude. Carlo Alberto avviò le trattative per ottenere un armistizio e nel frattempo abdicò in favore del figlio, Vittorio Emanuele II, per evitare delle condizioni troppo pensanti. L’armistizio di Vignale fu firmato il 24 marzo 1849 e concesse la Lomellina ed Alessandria agli asburgici. A questo trattato seguì la Pace di Milano il 6 agosto che determinò la cessazione delle ostilità tra i due contendenti.
Ciò che rappresentò maggiormente un esempio di rivoluzione democratica fu l’esperienza della Repubblica Romana dove si tentò di instaurare uno stato laico e di rinnovamento politico e sociale. Dopo l’esilio di Pio IX che si era rifugiato a Gaeta sotto la protezione di Ferdinando II, i repubblicani presero possesso della città. Le potenze europee cattoliche Austria, Spagna e anche la Francia che era ormai guidata da forze conservatrici si schierarono a favore del pontefice e ad inizio giugno le truppe transalpine attaccarono la capitale, la cui guida era stata affidata ad un triumvirato composto da Giuseppe Mazzini, Aurelio Saffi e Carlo Armellini. La Repubblica Romana prima di capitolare nel giro di un mese riuscì comunque ad approvare il testo della Costituzione.
Tutti questi tentativi di riformare in senso repubblicano i regni fallirono, tanto da parlare di seconda restaurazione dopo quella del congresso di Vienna del 1815. La sconfitta dei programmi repubblicani può essere spiegata sia dalla mancanza di una guida comune che unificasse tutti i singoli movimenti locali sia dalla borghesia che, spaventata dal socialismo e dalla crescita delle richieste da parte del proletariato, si riportò su posizioni monarchiche. Questo cambio di rotta a livello istituzionale è evidente in Germania e in Italia dove il processo di unificazione nazionale avverrà sotto la direzione delle forze conservatrici.
I moti del 1848
- Advertisment -
METEO
Comune di Caselle Torinese
foschia
13.5
°
C
14.2
°
12
°
93 %
4.6kmh
100 %
Mer
14
°
Gio
15
°
Ven
15
°
Sab
12
°
Dom
15
°
ULTIMI ARTICOLI
Cos’è l’amministrazione di sostegno?
Occorre prestare molta attenzione ai temi scelti questo mese dal nostro notaio, il dottor Gabriele Naddeo. Una sentenza del Consiglio di Stato chiarisce alcuni...