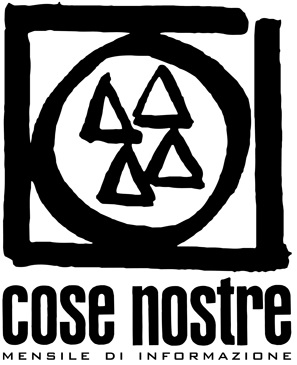Senza ombra di dubbio quelli di Giaglione e Venaus (Valle di Susa) sono “gli” Spadonari per eccellenza: ciò soprattutto in relazione al fatto che queste figure risultano più “pure”, poiché la loro danza è inserita con maggiore autonomia all’interno della festa, rispetto, per esempio, a quanto accade in altre località del Piemonte e della Francia.
Senza ombra di dubbio quelli di Giaglione e Venaus (Valle di Susa) sono “gli” Spadonari per eccellenza: ciò soprattutto in relazione al fatto che queste figure risultano più “pure”, poiché la loro danza è inserita con maggiore autonomia all’interno della festa, rispetto, per esempio, a quanto accade in altre località del Piemonte e della Francia.
A Giaglione il rito si svolge in gennaio, in occasione delle festività dedicate a san Vincenzo; quello di Venaus a febbraio, con le festività di san Biagio e sant’Agata. Vi è poi ancora il rito di San Giorio dove, in aprile, in occasione della festa di san Giorgio, gli Spadonari svolgono un rito legato alla ricostruzione della “Soppressione del feudatario”.
Tre località della Valle di Susa in cui la danza armata è segnalata con una certa consistenza dall’inizio del XIX secolo e si ripete come una presenza rilevante nell’ambito delle tradizioni rituali connesse al ciclo religioso. Alcune indagini d’archivio hanno però consentito di retrodatare il rito degli Spadonari al XVII secolo.
Un importante documento storico sulla danza armata in Valle di Susa riguarda i festeggiamenti organizzati a Susa, nel mese di aprile 1663, in occasione del passaggio di Carlo Emanuele II e di Francesca d’Orleans. Si tratta dell’opera di V. Castiglione, Le feste nuttiali delle Regie Altezze di Savoia descritte dall’abate don Valeriano Castiglione benedettino milanese loro historico, pubblicato a Torino appunto nel 1663. Sappiamo che quei festeggiamenti prevedevano “strepitose salve di moschetterie e di artiglierie dal forte, videro l’esercito di trenta giovani comparsi ad armeggiar con mota destrezza con spadoni”.
Si è ipotizzato che quei trenta giovani che armeggiavano con destrezza lo “spadone” in realtà fossero Spadonari, sostanzialmente simili a quelli attuali.
A sorreggere l’ipotesi giunge un documento conservato nell’Archivio di Stato di Torino, da cui abbiamo notizia che a Susa furono organizzate alcune iniziative per accogliere gli illustri sposi regali. Tra i partecipanti ai festeggiamenti la “compagnie des spadons” (Archivio di Stato di Torino, Sez. di Corte, Matrimoni Real Casa, m. 30, d. 7.).
È significativo, anche se non certo, che gli Spadonari abbiamo svolto un ruolo di primo piano nella celebrazione dei regali sposi, evidenziando così la funzione niente affatto secondaria della tradizione popolare, anche all’interno di un evento come quello costituito dal transito di due personaggi di rilievo.
Continuando a osservare le problematiche connesse all’origine delle danze armate valsusine, tra le ipotesi tendenti a spostare indietro nel tempo la loro datazione, troviamo quella che lega il rito degli Spadonari alle sacre rappresentazioni, che hanno come soggetto san Giovanni Battista e altri santi che avrebbero subito l’identico tipo di martirio. In questo senso la danza delle spade potrebbe essere considerata “una memoria sopravvissuta del culto delle têtes coupées, praticato dai Celti” (ne abbiamo parlato nel capitolo precedente).
A partire dalla metà del XIX secolo, le informazioni sugli Spadonari vanno aumentando offrendo quindi l’opportunità per tentare di ricostruire sul piano coreutico e scenico, lo sviluppo del rito.
Ecco cosa scriveva Norberto Rosa nel 1843: “Due o più uomini del contado, appositamente scelti ed ammaestrati, i quali indossate non so quali strane e miste assise del medio evo, e stretti certi enormi spadoni, procedono in capo alla comitiva, ballando una specie di moresca, o danza pirrica (…) anche Meana già l’adottò, essendovi in Giaglione un maestro che ne’ giorni festivi vi si reca a dare le sue lezioni” (N. Rosa – anche con pseudonimo Antonio Baratta – Festa di Santa Cecilia in Val di Susa, in “Museo scientifico, letterario e artistico”, V, 33, p. 259).
Studiosi come Regaldi (La Dora, Torino 1867) e Pola Falletti Villafalletto (Associazioni giovanili e feste antiche, Torino 1937, pag. 236) attestano la pratica della danza delle spade in altre località valsusine: Chiomonte, Chianocco, Vaie, Exilles.
Dal Regaldi, che scriveva nel 1867, apprendiamo che al suo tempo le danze armate valsusine ebbero un arresto: “da qualche anno quelli di Giaglione, di Venaus e di Chiomonte hanno deposto l’elmo e la serica sopravvesta, e gettato lo spadone tra i vani arnesi delle loro terre. Ultimi e soli rimasero gli spadeggiatori di San Giorio”.
Lo studioso aveva anche indicato alcune ipotesi sull’origine di quella singolare pratica rituale, suggerendo una serie di proposte che oggi risultano però poco accreditabili alla luce della ricerca etnografica moderna.