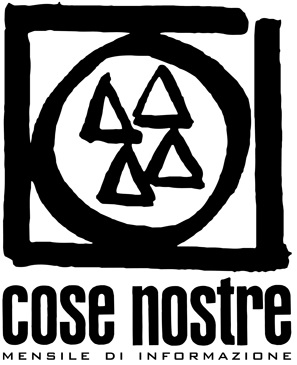Alla severità dell’opera lirica degli esordi ancora legata all’estetica tardorinascimentale, che ebbe in Monteverdi il suo rappresentante più alto, succedette uno stile che dava maggior spazio agli ariosi fino ad inserire delle vere e proprie Arie. Già nel 1649 con il “Giasone” di Francesco Cavalli l’apertura verso la cantabilità melodica si era fatta chiara, inevitabile, e si capiva che il “recitar cantando” si sarebbe presto trasformato in un “cantar recitando”: cioè campo ancor tutto da esplorare, mirabolanti spazi musicali e modalità espressive da scoprire. Di questi fermenti si nutrì non solo l’opera lirica, ma anche il più modesto ma non meno avvincente “Oratorio”.
Alla severità dell’opera lirica degli esordi ancora legata all’estetica tardorinascimentale, che ebbe in Monteverdi il suo rappresentante più alto, succedette uno stile che dava maggior spazio agli ariosi fino ad inserire delle vere e proprie Arie. Già nel 1649 con il “Giasone” di Francesco Cavalli l’apertura verso la cantabilità melodica si era fatta chiara, inevitabile, e si capiva che il “recitar cantando” si sarebbe presto trasformato in un “cantar recitando”: cioè campo ancor tutto da esplorare, mirabolanti spazi musicali e modalità espressive da scoprire. Di questi fermenti si nutrì non solo l’opera lirica, ma anche il più modesto ma non meno avvincente “Oratorio”.
Nato nell’ambiente delle congregazioni di San Filippo Neri, prima a Roma e poi nelle varie sedi sparse in tutt’Italia, ebbe come caposcuola un insigne frequentatore della “Camerata dei Bardi”, Emilio de’ Cavalieri, che all’esatto scadere del nuovo secolo presentò una sua sorprendente “Rappresentazione di Anima e Corpo”, il primo esempio di Oratorio che si conosca e tuttora punto saldo dello stile oratoriale. La scrittura era ancora quella dei mottetti dialogici, ma in tempi brevi si sarebbe fusa con la linfa vitale che già scorreva nelle opere liriche ed il genere avrebbe attinto alle alte vette del dramma.
Di solito l’Oratorio era diviso in due parti, in mezzo a cui veniva pronunciato un sermone, e si basava su testi appositamente scritti prendendo spunto da storie tratte dalla Bibbia, dai Vangeli o dall’agiografia dei santi. Veniva dato risalto all’orchestra, che non si limitava ad accompagnare ma spesso era chiamata ad eseguire anche brani solistici, ed agli interpreti dei vari ruoli, a cui erano spesso assegnati passaggi di vero virtuosismo come accadeva nei teatri. I cori partecipavano sottolineando o suggellando vari momenti della trama. Una figura chiamata “Testo” (ovvero “Historicus”) teneva unito il tutto con robusti recitativi alternati a pregnanti ariosi.
Un genere molto apprezzato di Oratorio che si sviluppò nell’ambito della scuola romana fu quello “in latino”. In esso si distinse in modo particolare Giacomo Carissimi (1605-1674), celebre in tutt’Europa per la sua capacità di esprimere ogni sfumatura del pathos. Fra i molti suoi oratori non si può non citare “Jephte”, uno dei grandi capolavori del genere. Il condottiero israelita Jephte per assicurarsi la vittoria contro gli Ammoniti fa voto a Dio di immolare il primo che, della sua casa, gli verrà incontro: sarà la sua unica figlia. La musica descrive eloquentemente il trionfo militare che a poco a poco si trasforma in tragedia, il terribile contrasto che vede da una parte la gloria di Israele e dall’altra la morte dell’innocente fanciulla, con in mezzo lo strazio insanabile del padre. Lo struggente lamento finale viene realizzato attraverso un coro a sei voci. A rendere “Jephte” un capolavoro fu la profonda compenetrazione tra musica e azione drammatica, un procedimento ancora ignoto persino nelle opere liriche coeve.
Dopo di che per quasi cento anni ci sarà un gran susseguirsi di “Caste Susanne”, “Davide e Golia”, “Giuditta e Oloferne”… Nell’ingente massa di prodotti che l’epoca barocca sfornò senza posa, spicca la fastosa “Juditha triumphans” di Antonio Vivaldi, allegoria delle vittorie veneziane sui Turchi, che brilla col luccicore dell’oro brunito.
All’Oratorio non mancarono soggetti ideali, cioè con figure astratte che interloquiscono fra loro, come nel notevole “Il trionfo del Tempo e del Disinganno” con musica di Georg Friedrich Haendel su testo del cardinale Pamphillj; a cui seguirà “L’Allegro, il Pensieroso, il Moderato” dello stesso Haendel. Il quale, una volta trasferitosi a Londra, diventerà un insuperato oratorista e per tutto il ‘700, grazie a lui, il genere non conoscerà mai cali di apprezzamento. Del resto anche le “Passioni” di ambito tedesco, in ispecie quelle di Johann Sebastian Bach, altro non erano che degli oratori. Lo stesso Mozart per un paio di volte fu sedotto da testi oratoriali, forse non eccelsi, ma risolti da lui in modo più che egregio (da ricordare il suo “Davidde penitente”); mentre Haydn riuscirà ad immettere nuova vita nell’antica struttura con due fantastici titoli: “La Creazione” e “Le Stagioni”. Scritti entrambi per Londra, dove il genere era sempre richiestissimo, furono e sono due possenti colonne dell’arte oratoriale. E persino Beethoven, all’alba di un Ottocento turbolentissimo, per una volta, una sola, vi si trovò intrappolato, nella fattispecie con “Cristo sul monte degli Ulivi”, di cui è notevole per lo meno l’Introduzione dal fosco colore romantico.
Ma era proprio il romanticismo a voltare le spalle a quell’antico attrezzo del tempo che fu. Per tutto secolo XIX ce ne furono ancora, tre o quattro, affetti da gigantismo e da ambizioni abnormi (Berlioz, Liszt), ma fu il più romantico fra tutti i musicisti, Robert Schumann, a mettere al mondo un ultimo capolavoro del genere, tratto da una delicata leggenda orientale, “Il Paradiso e la Peri”; storia dolce e triste, tenera e severa, con un rivestimento musicale intriso di luce e di eteree armonie. Trovo bello che la gloriosa vicenda storica si sia chiusa con una musica che si può solo definire paradisiaca.
La grande storia dell’Oratorio
- Advertisment -
METEO
Comune di Caselle Torinese
nubi sparse
13.7
°
C
14.6
°
12
°
89 %
2.6kmh
75 %
Mer
15
°
Gio
12
°
Ven
14
°
Sab
11
°
Dom
10
°
ULTIMI ARTICOLI
Parliamo di… Assicurazioni
Carissimi lettori,
torno sul tema delle assicurazioni condominiali, ed in particolare delle coperture delle polizze globale fabbricato.
Salvo eventuali opzioni aggiuntive acquistate, la polizza condominiale copre...