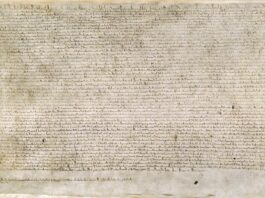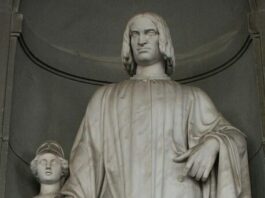La battaglia di Melegnano si ascrive all’interno degli innumerevoli scontri per la dominazione della penisola italiana da parte delle potenze straniere di turno. La storia è molto lunga ed è durata secoli, dalle prime invasioni barbariche che portarono alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente fino al 1861, anno dell’unificazione politica dell’Italia. La battaglia di Melegnano, che vide fronteggiarsi gli eserciti dei Francesi e degli Svizzeri tra il 13 e il 14 settembre 1515 per il predominio sul Ducato di Milano, viene considerata dalla storiografia contemporanea una delle battaglie più cruente e sanguinose di tutto il periodo rinascimentale. Francesco I, re di Francia, non ancora ventunenne e sul trono da pochi mesi, era stato guidato verso il Milanese da un’ambizione degna dei suoi antenati. Da loro aveva ereditato il disegno di espandere in Italia i propri possedimenti, a cominciare proprio dal ducato di Milano, contro il quale aveva schierato un potente esercito di 30 mila uomini e un’alleanza con la Repubblica di Venezia. A difesa del Ducato di Massimiliano Sforza, altrettante ingenti forze: innanzitutto gli Svizzeri, punta di diamante di una coalizione più ampia che comprendeva il Papato e la Spagna, i primi impedivano ai Francesi di entrare in Italia bloccando i valichi alpini a Pinerolo e a Saluzzo, i secondi contrastavano l’esercito di Venezia sul fiume Po. Come Annibale prima e Napoleone in seguito, il superamento della catena montuosa delle Alpi rappresentava un elemento determinante nella sorte della campagna militare. Da mesi, infatti, gli uomini di re Francesco esploravano le Alpi interrogando contadini e pastori alla ricerca di vie alternative per valicarle, giungendo, infine, a individuare una mulattiera che attraversava il passo presso il colle della Maddalena. Il superamento delle Alpi da parte francese provocò un effetto a sorpresa sugli avversari svizzeri, che sentendosi accerchiati abbandonarono immediatamente le loro postazioni in difesa dei passi alpini e presero in tutta fretta la via per Milano. Nel frattempo, Il re di Francia si fermò a Torino per fare una rapida visita di cortesia allo zio Carlo III, duca di Savoia, prima di riprendere il cammino verso Milano.
Nonostante i Francesi disponessero di un imponente esercito, tra le cui fila vi era anche un contingente di 9000 lanzichenecchi, il re Francesco temeva gli Svizzeri, la più potente fanteria dell’epoca, e avrebbe preferito di gran lunga trovare un accordo diplomatico piuttosto di rischiare un confronto militare. D’altra parte gli Svizzeri avevano già venduto quindici anni prima un duca di Milano ai francesi e ciò avrebbe potuto ripetersi. A tale scopo furono avviate delle trattative segrete con Albert von Stein, capo del contingente di Berna e sostenitore di Francesco tra le file elvetiche, il quale rese pubbliche le proposte francesi durante l’assemblea dei capitani delle forze riunite cantonali, l’organismo che faceva le funzioni di comando generale negli eserciti svizzeri. Il dibattito che ne scaturì divise in due l’assemblea: da una parte coloro che avevano già combattuto a sufficienza accumulando bottini nelle battaglie precedenti e che erano propensi all’accordo; dall’altra coloro che dall’occupazione del Milanese speravano di trarre un profitto altrettanto consistente. Quest’ultimi vennero appoggiati dal cardinale Matthäus Schiner, rappresentante del papa presso le armate svizzere e uno dei principali protagonisti della scena politica europea dell’epoca. A una sua perorazione appassionata della prosecuzione della guerra si aggiunse una schermaglia tra cavalieri milanesi e un contingente di esploratori francesi (forse provocata ad arte) che Schiner denunciò come un attacco a tradimento francese. Il pomeriggio del 13 settembre 1515 i bernesi e i loro alleati non tornarono sui loro passi e uscirono da Milano per la via settentrionale, abbandonando i loro connazionali che, al contrario, presero verso sud, a Melegnano, dove si era accampato l’esercito transalpino.
Fedeli alla loro consolidata tattica militare, gli Svizzeri si erano suddivisi in tre lunghe colonne e come in tante altre occasioni contavano sulla velocità della loro offensiva e sulla spietata e leggendaria ferocia delle loro alabarde. I Francesi, convinti che si giungesse all’accordo, furono colti di sorpresa e cedettero inizialmente all’impeto nemico. Il contrattacco disperato della loro cavalleria pesante costrinse gli Svizzeri a fermarsi, concedendo tempo alle fanterie francesi di riorganizzarsi e all’artiglieria di riprendere a sparare. Gli scontri proseguirono fino a notte inoltrata e all’alba del 14 settembre i due eserciti stanchi erano ancora lì a darsi battaglia. Se da una parte gli Svizzeri, con testardaggine, replicarono la stessa tattica offensiva della giornata precedente, dall’altra i Francesi avevano acquistato fiducia dall’efficace difesa che combinava la forza distruttrice dell’artiglieria con la mobilità della cavalleria. Anche nel secondo giorno i combattimenti vennero condotti nella medesima forma del giorno precedente, con gli Svizzeri che attaccavano e i Francesi in fase di arretramento. L’incrollabile tenacia dei confederati stava generando un sanguinoso stallo senza vincitori né vinti, quando sul campo di battaglia comparvero le avanguardie dell’esercito veneziano. L’equilibro era rotto: gli Svizzeri compresero di essere sconfitti e abbandonarono il campo. I superstiti raccolsero i feriti e si avviarono verso Milano. Francesco I si prese il ducato che mantenne per soli dieci anni, ma soprattutto aveva guadagnato un’alleanza elvetica in una pace perpetua che conferiva alla Francia il privilegio di arruolare i soldati dei Cantoni.